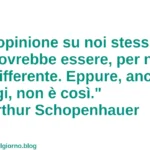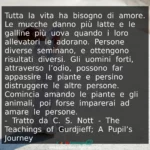Tutto è Uno: cosa significa secondo il Buddhismo Zen?
Estratto dal libro: ‘La via della liberazione nel Buddhismo Zen‘ di Alan Watts.
“La parola non può che esprimere che un frammento infinitesimale della conoscenza umana, dato che quanto possiamo pensare e dire è sempre incommensurabilmente minore di ciò che sperimentiamo.
Non solo perché non ci sono limiti alla descrizione esaustiva di un evento, come non ci sono limiti alle possibili divisioni di un’unità di misura, ma anche perché esistono esperienze che sfidano la struttura stessa del nostro linguaggio. E’ come se volessimo tenere l’acqua in un setaccio. Ma l’intellettuale, colui che ha la perfetta padronanza delle parole, corre continuamente il rischio di limitare il conoscibile a ciò che può essere descritto. […]
Ciò vale in particolare per un’idea che si affaccia ripetutamente nella storia della filosofia e della religione: l’idea che l’apparente molteplicità dei fatti, delle cose e degli eventi sia in realtà Uno, o, più correttamente, sia oltre la dualità. Quest’idea non è una semplice teoria speculativa, ma proviene dalla reale esperienza dell’unità, descrivibile anche come la sensazione che tutto quanto accade o può accadere è così positivamente giusto e naturale da poter addirittura essere chiamato divino. Per usare le parole dello Shinjinmei:
Uno è tutto;
Tutto è uno.
Se solo questo è possibile,
Perché angustiarsi per la propria imperfezione?
Per il logico un’espressione del genere suona priva di senso; per il moralista è semplicemente sovversiva. Lo stesso psicologo può chiedersi se possa esistere una condizione mentale o emotiva che sia fedelmente rappresentabile in questi termini, perché può voler sostenere che le sensazioni e i sentimenti sono riconoscibili solo in base alla reciproca differenza, come il bianco si riconosce dal contrasto col nero, e che quindi una sensazione di non-differenza, di totale unità è impensabile in assoluto. Al più sarebbe come mettersi degli occhiali rosa.
All’inizio si avrebbe coscienza delle nuvole rosa per contrasto col ricordo delle nuvole bianche, ma col tempo il contrasto svanirebbe, l’idea che il colore delle lenti tinge ogni cosa scomparirebbe dalla coscienza. Pure, la letteratura del Buddhismo Zen non fa pensare che l’esperienza di unità, o di non-dualità, sia solo temporanea e dovuta al contrasto con la precedente esperienza di molteplicità; fa ritenere invece che si tratti di un’esperienza immanente, che non svanisce assolutamente con la consuetudine. La miglior maniera per comprenderla sarà seguire, per quanto possibile, il modo in cui interiormente l’esperienza viene vissuta. Ciò significa, innanzitutto, considerarla dal punto di vista psicologico, per vedere se le parole esprimano, senso logico o convenzioni morali a parte, una realtà psicologica quale che sia.
Conflitto duale fra sé e l’ambiente
Si può ritenere che il punto di partenza sia la normale sensazione che ha l’individuo di un conflitto fra sé e l’ambiente circostante, fra i suoi desideri e le dure realtà della vita, fra il suo volere e le volontà discordanti degli altri. Il normale desiderio dell’uomo di sostituire a questo senso di conflitto un senso di armonia si riflette nell’eterna preoccupazione di filosofi e scienziati di comprendere la natura in termini di unità – nell’eterna insoddisfazione della mente umana rispetto al dualismo.
Vedremo che questo è per molti versi un punto di partenza alquanto insoddisfacente. Il problema di dover spiegare a qualcuno come arrivare da questo punto all’esperienza dell’unità richiama alla mente la storia del contadino a cui viene chiesta la strada che porta a un villaggio sconosciuto. Il contadino si gratta la testa per qualche secondo, poi risponde: “Ecco signore, io so dove sta, ma se fossi in lei per arrivarci non partirei da qui”. Solo che, sfortunatamente, è proprio qui che noi stiamo.
Le risposte della filosofia Zen
A questo punto, consideriamo alcuni dei modi in cui i maestri Zen hanno affrontato il problema. In particolare quattro modi meritano speciale attenzione, e si possono elencare brevemente così:
- Rispondere che tutte le cose sono in realtà Uno.
- Rispondere che tutte le cose sono in realtà il Nulla, il Vuoto.
- Rispondere che tutte le cose sono perfettamente giuste e naturali così come sono.
- Affermare che la risposta è nella domanda o in colui che la pone.
La stessa domanda può assumere molte forme diverse, ma sostanzialmente consiste nel problema della liberazione dal conflitto, dalla dualità, da quello che il Buddhismo chiama il samsara o il circolo vizioso della nascita-morte.
Principio di identità ultima delle cose
- Come esempio del primo tipo di risposta – l’affermazione che tutte le cose sono in realtà Uno – si considerino le parole di Eka:
- La profonda verità è nel principio dell’identità ultima delle cose. Sotto l’effetto dell’illusione la gemma del mani può essere definita una piastrella rotta. Ma quando entri nel vero autorisveglio è un’autentica perla. Il sapere e l’ignoranza sono una sola e medesima cosa. Dovresti sapere infatti che le diecimila cose hanno tutte la stessa Identità (tahata). E’ per compassione di quei discepoli, che mantengono una visione dualistica, che scrivo queste parole e invio questa lettera. Se consideriamo questo corpo e il Buddha come né diversi né separati, perché dovremmo inseguire qualcosa che non abbiamo bisogno di aggiungere a noi stessi?
L’implicazione di questa risposta è che la liberazione dal conflitto della dualità non richiede nessuno sforzo per cambiare nulla. Basta comprendere che ogni esperienza è identica all’Uno, la natura di Buddha, o il Tao e il problema semplicemente svanisce.
Per esempio quando Joshu chiede a Nansen: “Che cos’è il Tao?”, Nansen risponde: “La tua mente ordinaria è il Tao”. “Come si può tornare in armonia con essa?”, chiede Joshu. E Nansen: “Volendo l’armonia immediatamente te ne allontani.”
La reazione psicologica a risposte di questo genere è normalmente il tentativo di sentire che ogni esperienza, ogni pensiero, sentimento o sensazione è il Tao: che in qualche modo il bene è lo stesso che il male, il piacevole lo stesso che il doloroso. Questo può prendere la forma dell’applicare a ogni esperienza, via via che la si incontra, il pensiero-simbolo “questo è il Tao”, quantunque ovviamente può essere difficile sentire un forte contenuto, un grande significato in un simbolo che si applica indifferentemente a ogni possibile esperienza. E tuttavia, allorché si presenta la frustrazione del non sentire alcun contenuto, ci si dice che anche questo è il Tao – così che qualsiasi comprensione di quale possa essere la natura di questo Uno che è Tutto diventi via via più elusiva.
Tutte le cose sono Nulla o Vuoto
2. A questo punto, un altro e forse migliore modo di rispondere alla domanda originaria è affermare che tutte le cose sono in realtà Nulla o Vuoto (shunyata), come dice il Prajnaparamita-bridaya-sutra. “La forma è esattamente il vuoto; il vuoto è esattamente la forma.” Questa risposta non provoca nessun tentativo di ricerca di contenuto o significato nel termine usato per rappresentare la realtà dell’Uno.
Nel Buddhismo la parola shunya, o vuoto, implica inconcepibilità più che semplice nulla. La risposta psicologica all’asserzione che tutto è Uno potrebbe essere definita un tentativo di dire “Sì” a qualsiasi esperienza via via che si presenta, un tentativo di raggiungere una totale affermazione o accettazione della vita in tutti i suoi aspetti. Al contrario, la risposta psicologica provocata dall’affermazione che tutto è Nulla o Vuoto dovrebbe essere il tentativo di dire “No” a qualsiasi esperienza.
Troviamo la stessa cosa nel Vedanta, dove la formula neti, neti, “non questo, non questo”, è usata per favorire la comprensione che nessuna esperienza è la realtà dell’Uno. Nello Zen, il termine mu – non, nessuno o niente – si usa in modo analogo, e viene spesso impiegato come koan o problema di iniziazione nella meditazione del principiante, che viene messo in ogni momento e circostanza nella condizione di dover rispondere continuamente ‘No’. […]
Non fare assolutamente nulla
3. Ci sono quindi le risposte che sembrano implicare che non si deve fare assolutamente niente, neanche dire ‘Sì’ a tutto o ‘No’ a tutto. La chiave qui è abbandonare la mente e l’esperienza a se stesse e lasciare che siano né più né meno che quelle che sono.
Si rifletta su questo brano di Rinzai:
Si può risolvere il karma passato solo nel momento in cui si presentano le circostanze. Quando è il momento di vestirsi, vestitevi. Quando dovete camminare, camminate. Quando dovete sedervi, sedete. Non pensate minimamente a cercare la Buddhità. Come può essere? Gli antichi dicono: “Se ti proponi espressamente di cercare il Buddha, il tuo Buddha è solo Samsara…”. Seguaci del Tao, non c’è posto nel Buddhismo per l’uso dello sforzo. Siate semplicemente come siete, senza niente di particolare. Svuotate l’intestino, lasciate scorrere l’acqua, vestitevi e consumate i vostri pasti. Quando siete stanchi, andate a riposare. Gli ignoranti possono deridermi, ma i saggi capiranno. Gli antichi dicono: “Per poterti imbattere in un uomo del Tao mentre cammini, devi prima di tutto non avere il Tao di fronte. Ugualmente si dice che se una persona si esercita nel Tao, il Tao non opera.”
Analogamente, a un monaco che gli chiede: “Noi ci vestiamo e mangiamo ogni giorno: come evitare di doverci vestire e dover mangiare?”, Bokuju risponde: “Vestendoci; mangiando”. “Non capisco” obietta il monaco. “Se non capisci, vestiti e mangia.” In altri casi, lo stato di non dualità è rappresentato come qualcosa al di là degli opposti del caldo e del freddo; ma rischiesto di descrivere questo stato, lo Zen dirà:
Quando è freddo, ci raduniamo attorno al focolare,
davanti al fuoco che divampa;
Quando è caldo, sediamo sulla riva del torrente
montano, nel boschetto di bambù.
Qui la risposta psicologica sembra quella del lasciare che la propria mente risponda alle circostanze secondo come sente, senza entrare in conflitto con la sensazione del caldo in estate e del freddo in inverno, e – va aggiunto- senza entrare in conflitto con la sensazione che vi sia una sensazione con cui entrare in conflitto! Il che equivale a dire che il modo in cui si sente veramente è il modo giusto di sentire, e che il conflitto di fondo fra noi stessi e la vita si deve al fatto che noi cerchiamo di cambiare o di respingere la sensazione del momento. Insieme, questo stesso desiderio di sentire in maniera diversa può essere l’emozione del momento che non dev’essere cambiata.
Nella domanda c’è la risposta
4. C’è infine il quarto tipo di risposta, che ritorce la domanda su se stessa o su colui che l’ha fatta. Eka dice a Bodhidharma: “La mia mente non è in pace. Ti prego, pacifica la mia mente”. Bodhidharma risponde: “Portami la tua mente, e la pacificherò”. “Ma quando cerco la mia mente non riesco a trovarla” ribatte Eka. “Ecco, ho pacificato la tua mente”, conclude Bodhidharma.
Doshin chiede a Sosan: “Qual è la via della liberazione?” Il maestro risponde: “Chi ti tiene prigioniero?”. “Nessuno”. “E allora”, chiede il maestro, “perché dovresti cercare la liberazione?”
Ci sono altri esempi in cui la risposta è semplicemente nella ripetizione della domanda, o in una reazione del tipo: “La tua domanda è perfettamente chiara. Perché me la poni?”.
Risposte come questa sembrano riportare bruscamente l’attenzione sullo stato mentale che genera la domanda, come a dire: “Se le tue emozioni ti disturbano, scopri chi o che cosa è che viene disturbato”.
La risposta psicologica è quindi nel cercare di sentire chi sente e di conoscere chi conosce: fare del soggetto l’oggetto.
Pure, come dice Obaku, “Far sì che il Buddha cerchi se stesso o che la mente si impadronisca di sé è una cosa di per sé impossibile fino alla fine dei secoli”. Secondo Ekai: “E’ lo stesso che cercare un bue standogli sopra”, o come dicono i versi di una delle poesie dello Zenrin Kushu, è:
Come una spada che ferisce, ma non può
ferire se stessa;
Come un occhio che vede, ma non può
vedere se stesso.
[…] Se tutte le cose sono l’Uno, ecco che anche il mio senso di conflitto di fronte alla dualità è l’Uno, così come lo è la mia obiezione a questo sentimento. Se tutte le cose sono Vuoto, ecco che anche il pensiero di questa realtà è Vuoto, e io sento come se mi si chiedesse di cadere in una buca e tirarmi la buca dietro.
Se tutto ciò che accade è perfettamente giusto e naturale, ecco che anche l’errore e l’innaturale lo sono. Se io devo semplicemente far accadere le cose, che succede se una di queste cose è proprio il mio desiderio di interferire nel corso delle cose? E infine, se la radice del conflitto è nella mancanza di autocomprensione, come posso comprendere il me che sta cercando di comprendersi? In breve, l’origine del problema è nella domanda. Se non poni la domanda, il problema non sorge. In altre parole, il problema di come sfuggire al conflitto rappresenta lo stesso conflitto da cui si cerca di sfuggire.

|  € 18,60 |
Due conclusioni precise
Se tutte queste risposte non sono di particolare aiuto, ciò sta solo a significare che la condizione umana è una condizione senza scampo. Ogni rimedio alla sofferenza assomiglia in definitiva al cambiare posizione in un letto scomodo, e ogni passo avanti nel controllo del nostro ambiente lo rende soltanto più difficile da controllare. Ciò nondimeno, tutti questi giri mentali sembrano portarci alla fine a due conclusioni piuttosto precise. La prima è che, se non cerchiamo di aiutarci, non ci renderemo mai conto di quanto siamo impotenti. Soltanto ponendoci domande all’infinito potremo cominciare a renderci conto dei limiti, e quindi della stessa costituzione, della mente umana.
La seconda è che, quando finalmente ci rendiamo conto degli abissi della nostra impotenza, attingiamo la pace. Ci siamo dati per sconfitti, che è ciò che si intende quando si parla di abbandono di sé, di autorinuncia o di resa totale.
Forse questo getterà una qualche luce sulla teoria buddhista del Vuoto, sull’affermazione che tutto è in realtà vacuo e vano. Se infatti l’impulso più profondo del mio essere è di sfuggire a un conflitto che è sostanzialmente identico al mio desiderio di sfuggire al conflitto, se in altre parole l’intera struttura di me stesso, del mio io, è un tentativo di fare l’impossibile, ciò significa che io sono vano o vuoto fino all’ultima particella di me stesso. Sono semplicemente un prurito che non ha nulla contro ci grattarsi. Il tentativo di grattarsi peggiora il prurito, ma un prurito è, per definizione, ciò che chiede di essere grattato.
La circolarità: desiderio di armonia e conflitto
Lo Zen tenta quindi di trasmettere la consapevolezza immediata della circolarità che ritorna su se stessa, della mancanza di scampo e della totale assurdità della condizione umana, di quel desiderio di armonia che in realtà è conflitto, di quell’ansia al fondo di noi stessi che è la nostra stessa volontà di vivere. […] Quando diventa chiaro al di là di ogni possibile dubbio che il prurito non può essere grattato, ecco che cessa da solo. Quando si arriva a comprendere che il nostro stesso desiderio di fondo è un circolo vizioso, spontaneamente il circolo si ferma. Ma accade solo quando è diventato chiaro e certo che non c’è modo di farlo fermare.
Il tentativo di far fare o non fare a se stessi una certa cosa implica, naturalmente, una dualità interiore, soggettiva – uno spaccarsi in due della mente che produce una paralisi nell’azione. In qualche grado, quindi, l’affermazione che tutto è Uno e Uno è tutto esprime concretamente la fine di questa spaccatura interiore e la scoperta dell’originale unità e autonomia della mente. E’ un po’ come quando uno impara ad usare un nuovo muscolo: tutt’a un tratto lo muove da dentro, o piuttosto è il muscolo stesso che si muove spontaneamente, dopo che tutti gli sforzi di farlo muovere dall’esterno sono risultati vani. Questo tipo di esperienza è notevolmente intenso, ma, come tutti sappiamo, impossibile da comunicare.